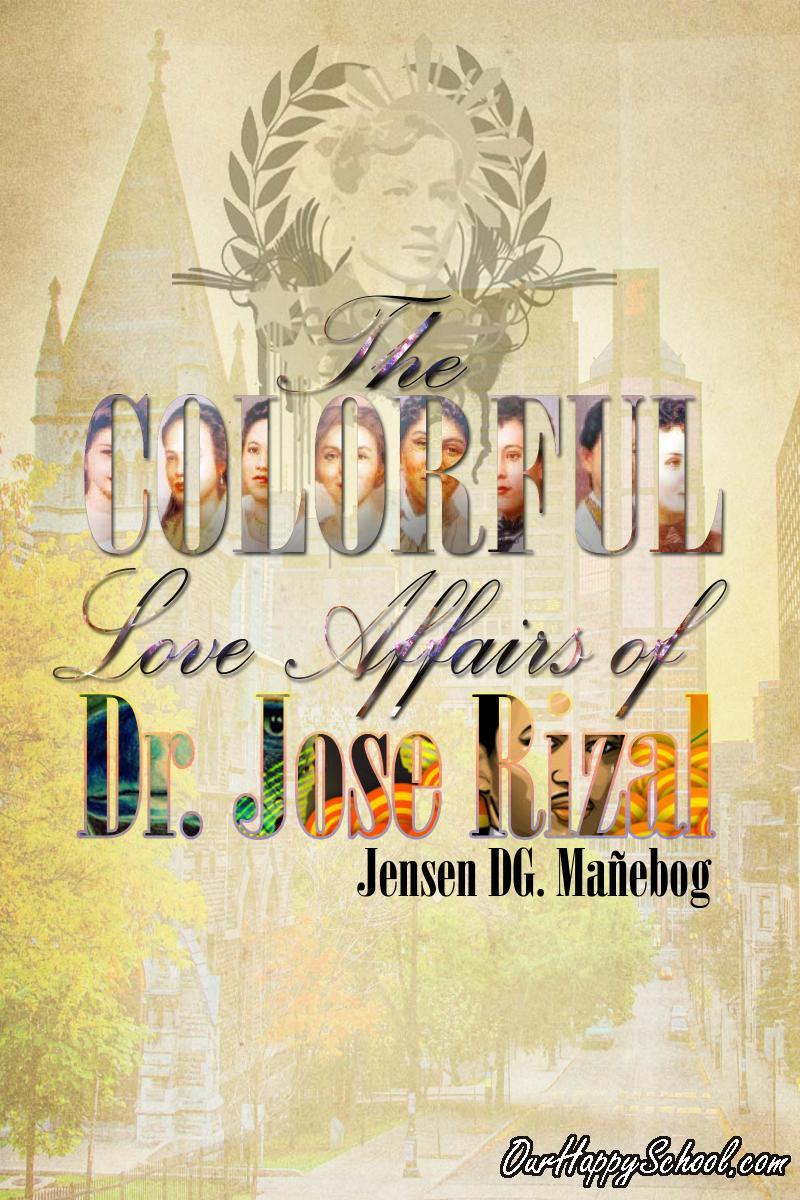«Che cosa è reale?», chiedeva Morpheus a Neo in Matrix, mentre tentava di spiegargli quale fosse la natura della matrice e in cosa consistesse – davvero– la realtà. Era il 1999, e tutti noi guardando il film ci siamo posti a nostra volta il medesimo, inquietante, interrogativo. In quegli anni, probabilmente, qualcosa iniziava a cambiare nella percezione comune. Disorientati dalla diffusione crescente dei videogiochi e dall’abitudine a effetti speciali sempre più sofisticati, iniziavamo ad accordare un credito inatteso alle vaghe lusinghe della virtualità, firmando un assegno in bianco al suo sorprendente potenziale di illusione. La stupefacente storia di Matrix era riuscita a insinuare un sospetto in ciascuno di noi: a chi, dopo aver visto il film,non è sembrato di intravedere almeno un’impercettibile incongruenza nella propria vita, un dettaglio poco convincente che ne metteva in dubbio la veridicità? E ancora: come è stato possibile che la simulazione, il virtuale, sia arrivato di punto in bianco a essere talmente persuasivo da insidiare l’esclusiva della credibilità alla realtà stessa? Attraverso quale percorso è riuscito a transitare dal dominio fanciullesco del gioco a quello estremamente serio della vita stessa? «Pillola azzurra: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa: resti nel paese delle meraviglie, e vedrai quanto è profonda la tana del coniglio». Che cosa scegli?
Il gioco, la simulazione, servono come esercitazione per imparare ad affrontare la realtà in un ambiente protetto. Il bambino gioca per acquisire delle competenze specifiche che gli consentiranno, da grande, di relazionarsi con situazioni molto più complesse. Nel gioco apprende come reagire di fronte all’imprevisto, ma soprattutto come svolgere una parte, interpretare un ruolo. L’informatica ha fornito un impulso considerevole nello sviluppo della tecnologia della simulazione, trasformandola in una vera e propria tecnica di apprendimento, usata ormai sempre più frequentemente anche in contesti di training operativo. Una delle più classiche applicazioni è costituita dal simulatore di volo, adoperato dai piloti per imparare a interagire con i comandi complicati della plancia di un aeroplano; ma se ne riscontrano impieghi altrettanto efficaci in ambito chirurgico o militare, e più in generale in tutte quelle discipline in cui è importante esercitarsi in un contesto protetto. Il rigoroso disaccoppiamento fra realtà e finzione – caratteristico della simulazione – si fa garante di quello che potremmo definire«principio di immunità»: tale principio assicura che nulla di ciò che viene compiuto nell’ambiente simulato possa avere alcun tipo di ripercussione nel mondo reale, in termini di danni economici o di pericolo per la vita umana.
A partire dai primi anni ottanta, con la diffusione dei videogiochi da bar e dei personal computer, i dispositivi di simulazione hanno subito un deciso incremento, sia a livello di popolarità che di perfezionamento tecnologico. Un videogioco è caratterizzato da tre componenti fondamentali: 1. un dispositivo di input– generalmente un joystick, un mouse o una tastiera (o una combinazione di questi) – attraverso il quale l’utente interagisce con il sistema; 2. un computer, che elabora l’input fornito dall’utente e produce immagini e audio in dipendenza dei dati ricevuti; 3. un dispositivo di output, che consente al fruitore del gioco di visualizzare le immagini e ascoltare l’audio prodotto dall’elaboratore. Il device che consente la visualizzazione delle immagini consiste in un display di dimensioni più o meno ampie, all’interno del quale viene rappresentata la simulazione. Il display è delimitato da una cornice che ne evidenzia i contorni, e che disegna in modo nitido il confine che separa lo spazio della realtà da quello della finzione. Ciò che rimane all’esterno della cornice è la realtà; quanto si muove all’interno del video è simulazione. Quanto più la rappresentazione somiglia alla realtà, tanto più il gioco è convincente. Come sa chi ha partecipato a una selezione lavorativa presso un’azienda che produce videogiochi, le competenze che maggiormente vengono accertate in sede di colloquio sono relative piuttosto alla conoscenza delle leggi fisiche che non alla tecnologia informatica. Ciò che un buon videogioco deve necessariamente offrire è un modello verosimile della realtà. Il tema del gioco può anche essere di argomento fantastico, ma la materia rappresentata deve poter essere percepita sensorialmente in maniera realistica.
Il passaggio dal paradigma del videogame a quello dellavirtual reality ha reso più efficacii sistemi di simulazione tramite il perfezionamento tecnologico dei tre componenti fondamentali illustrati in precedenza. Nella realtà virtuale il dispositivo di input non consiste più in un semplice joystick, che imita il movimento nello spazio in maniera estremamente semplificata, attraverso un procedimento ad alto livello di astrazione: essa si serve di un rilevatore dei movimenti realmente compiuti dall’utente, che attraverso dei sensori ne individua le coordinate nel sistema di riferimento, ovvero la posizione nello spazio. Tale dispositivo può consistere in un guanto da indossare (il cosiddetto Glove Input Device) oppure in meccanismi più complessi, come degli esoscheletri in grado di percepire una pluralità molto estesa di movimenti. L’elaboratore – che riceve le informazioni dai sensori e genera le immagini e l’audio corrispondenti alla posizione del giocatore – è dotato di una potenza assai superiore rispetto a quello di un semplice videogioco, in particolar modo per quanto concerne la velocità di elaborazione di immagini in tempo reale, ovvero in grado di adeguarsi rapidamente ai movimenti compiuti nello spazio virtuale.
La complessità di tali elaborazioni ha guadagnato a questa tipologia di calcolatore il nome di reality engine (generatore di realtà). La definizione può sembrare per certi versi ambiziosa, ma rende conto dell’obiettivo di questa tipologia di dispositivo, capace di provocare la cosiddetta «sospensione dell’incredulità». Affinché la realtà virtuale sia efficace nelle sue funzioni – didattiche o di puro intrattenimento – c’è infatti bisogno che il risultato finale sia il più possibile convincente, che non ne venga messa in dubbio la verisimiglianza. I dispositivi di output (ovvero di resa sensibile, il cosiddetto rendering) devono essere particolarmente sofisticati, per fornire al fruitore informazioni il più possibile ampie e perfezionate circa la realtà generata dall’elaboratore. I risultati ottenuti sotto questo aspetto dai videogiochi erano palesemente insoddisfacenti, in quanto il troppo evidente discrimine della cornice di un display non consentiva di sostenere l’illusione della realtà in maniera sufficientemente credibile. Tutto si gioca al livello dei sensi: in particolare della vista, poi dell’udito e – con minore importanza – tutti gli altri.
Nei sistemi di realtà virtuale le stesse strutture utilizzate per catturare l’input dell’utente sono solitamente dotate anche dei dispositivi di output. Il più comune è costituito da un particolare casco denominato HMD (Head Mounted Display, ovvero video montato sul capo), generalmente provvisto di uno schermo posizionato di fronte a ciascun occhio per consentire una visione stereoscopica (con conseguente effetto 3D), e di coppie di cuffie per la riproduzione dell’audio spazializzato, ovvero in grado di adeguarsi agli spostamenti dell’utente nello spazio virtuale. Alcuni sistemi particolarmente complessi inviano degli stimoli percepibili anche dagli altri sensi: è interessante la simulazione di una sensazione termica, o delle informazioni relative al senso del tatto e della forza, in termini di resistenza dei corpi e di retroazione (il cosiddetto haptic). Anche il senso dell’equilibrio può essere reso attraverso l’uso di una piattaforma mobile. La simulazione in tempo reale di altri sensi, come il gusto e l’olfatto, è ancora troppo costosa con le attuali conoscenze scientifiche e gli strumenti tecnologici oggi a disposizione; la sua assenza in ogni modo non sembra compromettere lo stato di sospensione dell’incredulità necessario per una fruizione efficace della realtà virtuale.
L’evoluzione dal videogioco a una vera e propria realtà alternativa – appunto, virtuale –, nella quale la simulazione viene sperimentata in maniera immersiva, ha costituito una novità assoluta dal punto di vista tecnologico, ma ancor più da quello esperienziale. Tale cambio di paradigma ha creato una potente illusione: che la realtà virtuale possa conservare il privilegio di un ambiente protetto – garantito dal principio di immunità – e al tempo stesso continuare a offrire una sensazione di effettività, di pienezza (di solito riscontrabile esclusivamente nella realtà), raggiunta grazie alla sospensione dell’incredulità.
In ambito cinematografico, l’enorme potenziale racchiuso in questo genere di dispositivo è stato sfruttato fin dai primi anni novanta, quando uscì nelle sale Il tagliaerbe (1992). Il film narra levicende di Jobe, un ritardato mentale che con l’aiuto di un sofisticato software di simulazione arriva a sviluppare in modo sorprendente la propria intelligenza. In questa pellicola la simulazione consiste in un universo videoludico che rimane parallelo (e dunque esterno) rispetto a quello reale – conformemente a quanto garantito dal principio di immunità –, anche se diviene presto molto chiaro che tra i due universi è possibile stabilire delle connessioni. Che la realtà vera possa influenzare quella virtuale è particolarmente lampante, dal momento che ne rappresenta il modello primario; ma che questa a sua volta influenzi il mondo reale, nel film è altrettanto evidente per almeno due motivi. Innanzitutto, grazie al training effettuato, Jobe diventa realmente più intelligente, capace di affrontare situazioni concrete che nella sua iniziale condizione di ritardato era impreparato a sostenere. In secondo luogo, dopo aver imparato a interagire con i mondi simulati prodotti dal sistema di virtualizzazione, egli diviene in grado di modificare digitalmente il mondo materiale che lo circonda, stabilendo un’ambiguità di fondo tra realtà vera e realtà virtuale destinata a rivelarsi assai feconda nella cinematografia successiva.
Il tema della confusione tra diversi livelli percettivi si afferma nella seconda metà degli anni novanta in un vero e proprio filone che straripa dai confini della fantascienza in senso stretto. Nel gioco, nel viaggio nel tempo, nello sdoppiamento di personalità, nel sogno, nell’alterazione della memoria, nella virtualizzazione informatica, nella mutazione sociale, nella fiction, l’uomo sperimenta una realtà alternativa che percepisce come preferibile o comunque più persuasiva rispetto alla realtà vera, e che ne insidia nella sua coscienza l’atavico monopolio della verità. I turbamenti sottocutanei che agitavano la neonata società virtuale – sovreccitata dalla diffusione globale di internet, dall’ingannevole frenesia del Nasdaq, dall’inquietudine che abitava il benessere illusorio della new economy – si affacciavano alla ribalta della consapevolezza, andando a incrinare quello che sembrava uno dei fondamenti della civiltà e dell’esistenza stessa: la percezione nitida, inconfutabile, esatta della realtà.
In Fight Club (1999) le esigenze della produzione industriale e la logica di mercato hanno orientato il focus primario della collettività verso la definizione sempre più ossessiva di criteri di efficienza. L’individuo non viene più considerato per ciò che lo distingue, ma per ciò che lo rende simile agli altri. Lo standard si impone a discapito della differenza,il senso estetico viene soppiantato dalla funzionalità, l’impegno personale da un ecumenico rispetto delle procedure. Alla perversione della pornografia, degenerazione di un sano istinto individuale, è subentrata quella dell’arredomania, una sorta di feticismo sociale difficileda ricondurre al bisogno primario che lo ha determinato. In questo scenario, un impiegato insonne e depresso tenta di estrinsecare la propria riottosa intensità tramite esperienze estreme – come il confronto morboso con la sofferenza, lo sprezzo del pericolo, il corteggiamento della morte –nell’angosciosa ricerca di un’autenticità che non possa essere messa in discussione. La distanza sempre più profonda che separa l’anonimato della sua esistenza quotidiana dall’irruenza esasperata delle sue pulsioni fa sì che egli giunga a sviluppare una seconda, distinta identità, alla quale attribuisce una vita separata dalla propria. L’uomo si lega al suo alter ego in un sodalizio di natura schizofrenica, e insieme a lui fonda il Fight Club, un circolo segreto in cui nei fine settimana la gente va a fare a pugni per ritrovare nelle emozioni forti e nel dolore quella conoscenza di sé che la società le aveva sottratto. L’evidente inconciliabilità dei due distinti livelli percettivi induce l’anonimo protagonista a vivere la propria disubbidienza in maniera paranoica, incapace di incanalare l’efferatezza dei propri istinti in una modalità conciliabile con le convenzioni, impossibilitato a sanare la propria dissociazione nei contorni unitari di un’accettabile vita reale.
In Matrix gli uomini si illudono soltanto di avere una vita reale. Essi sono mantenuti artificialmente in uno stato vegetativo, mentre nella loro mente viene creata l’illusione della realtà attraverso un software innestato direttamente nel sistema nervoso.Viene loro negata perfino la possibilità di scegliere tra un livello di esistenza e l’altro. Sono obbligati a vivere all’interno di Matrix, credendo che il presente sia la Terra del 1999, senza sospettare di vivere in realtà due secoli dopo, su un pianeta ridotto in macerie dalla guerra, all’interno di sterminati campi di coltivazione in cui le macchine clonano gli esseri umani al solo scopo di trarne energia. Per ottenere una piena consapevolezza, Neo – l’eletto destinato a liberare gli uomini dalla schiavitù – deve prima di tutto soffocare la propria istintiva repulsione a considerare come un inganno tutto quanto fino a quel momento aveva reputato vero. La pillola rossa – con la quale avrebbe conosciuto la verità, risvegliandosi dal sonno artificiale e predisponendosi alla liberazione fisica dal campo di prigionia – gli richiede un profondo atto di umiltà. Egli deve porre in discussione le proprie certezze e infrangere quella sospensione dell’incredulità magistralmente ottenuta dalla spettacolare simulazione di Matrix.
Ripristinare l’incredulità significa per Neo mettere in discussione la fondatezza degli enti e degli eventi all’interno del programma. Se la mente non crede a ciò che gli occhi percepiscono, è facile alterare il tessuto materiale delle cose. Se si crede che il cucchiaio non esista, esso può perdere la sua consistenza deformandosi in modo grottesco. Se le leggi fisiche sono solamente una riproduzione digitale – per quanto assai sofisticata – della realtà, non è impossibile camminare in verticale sulle pareti, fare un salto di trenta metri, o subire la trafittura delle pallottole senza subire un danno biologico. D’altro canto è vero anche il contrario: credendo nella fondatezza assoluta di quanto si percepisce, un incidente mortale avvenuto all’interno di Matrix può determinare la morte drammaticamente reale di un individuo.
In un’altra pellicola degli anni novanta, The Truman Show (1998), è rappresentato un gigantesco set televisivo nel quale la vita intera di un uomo – a partire dal giorno della nascita – viene ripresa e trasmessa in diretta TV, in una sorta di reality show nel quale l’uomo è del tutto inconsapevole della finzione alla quale sta prendendo parte. I suoi familiari e gli abitanti della cittadina in cui abitasono attori; le ambientazioni sono delle sofisticate scenografie nascoste; gli episodi cruciali della sua vita sono l’oggetto di una sceneggiatura studiata nei minimi dettagli. Incapace come Neo di discernere tra verità e finzione, anche Truman intuisce che al di sotto della realtà si cela qualcosa di anomalo. (Per quanto ben costruita possa essere una simulazione, è impossibile che nel suo tessuto non traspaiano delle incongruenze. Chi riuscisse a simulare un universo in tutto identico a quello reale ne avrebbe rubato il progetto nel cassetto di Dio). E – ancora come Neo – cerca di fuggire dall’inganno forzando le stesse imperfezioni del sistema. Resta memorabile la scena finale, nella quale Christof, l’ideatore dello show, cerca di fermare Truman nel suo tentativo di evadere dalla simulazione a bordo di una barca a vela. Entrando nel programma meteorologico, Christof scatena una violenta tempesta che rischia di uccidere Truman in diretta.
La disinvolta padronanza delle leggi fisiche e dei fenomeni naturali ostentata dall’uomo nella realtà simulata evoca il passo vetero testamentario del libro di Giobbe, nel quale l’Eterno rammenta al suo servo la propria onnipotenza passando in rassegna un vasto repertorio di fenomeni atmosferici: «Dove eri tu quando fissavo le fondamenta della terra? Chi chiuse con porte il mare? Io gli fissai un limite, gli posi dei catenacci e porte. Quale via conduce alla dimora della luce? E la tenebra dove si trova? Sei mai penetrato nei depositi della neve? I depositi della grandine, li hai visti? Chi ha tracciato i canali per la pioggia e fissato la via al temporale? A un tuo ordine partono forse i fulmini?». Al pari dell’Onnipotente, anche l’ideatore dello show ha – nella realtà simulata – gettato le fondamenta della terra e fissato i limiti del mare. Anch’egli fa sorgere il sole e lo fa tramontare. Anch’egli ha il controllo della pioggia, della grandine e della neve, e il potere di comandare ai fulmini. Anch’egli, infine, si presenta alla sua creatura (nella finzione) dicendo: «Io sono il creatore… dello show televisivo», con una pausa a effetto tra il predicato nominale e il complemento di specificazione che conferisce al termine «creatore» un’efficace connotazione di assolutezza.
La progressiva erosione del concetto di realtà a opera dell’esperienza simulata riscontrata nella cinematografia degli anni novanta persiste anche nel primo decennio del secolo attuale. In Memento (2000) la normale percezione della realtà è resa impossibile da un disturbo della memoria che non consente di trattenere i ricordi a breve termine. In Vanilla Sky (2001) a una realtà tragicamente inaccettabile viene preferita un’immaginazione onirica vissuta in stato di coma criogenico. Minority Report (2002) accorda una significativa preminenza alla premonizione rispetto all’oggettività dei fatti effettivamente accaduti. In Paycheck (2003) è la manipolazione della memoria a determinare l’inconsistenza della realtà, mentre in The butterfly effect (2004) l’alterazione degli eventi passati determina una destabilizzante mutevolezza del presente.
È il sintomo di una graduale perdita di consistenza da parte della realtà, sottoposta a continui e sistematizzati procedimenti di astrazione che agiscono sui referenti del codice indebolendone o alterandone la solidità. Ma è anche la testimonianza di una progressiva ingerenza della virtualità nella vita quotidiana. Basti pensare al denaro virtuale e all’abitudine sempre più frequente ai pagamenti tramite bancomat o carta di credito; ai programmi di word processing, che hanno eliminato quasi interamente la consuetudine della scrittura manuale; ai social network, che hanno invaso a livello sociologico le modalità quotidiane della comunicazione; ai navigatori satellitari, che affrancano l’automobilista dallo sforzo di decifrazione del territorio, limitando la sua attività all’obbedienza inconsapevole a una voce guida.
Tutti questi fenomeni attestano uno spostamento di focus riscontrabile nella generazione attuale dalla manifestazione materiale, corporea della realtà, verso una simbolica, legata alla rappresentazione. Il concetto di segno viene decostruito,e il referente ne diviene un aspetto ridondante, ingombrante, non più necessario. Chi conosce il codice si accontenta del significato. La garanzia della referenzialità del segno viene esternalizzata a terzi: al sistema bancario per le carte di credito, ai provider per le web community, al file system per la videoscrittura, al GPS per la navigazione satellitare. Il mondo reale nutre un interesse sempre più rilevante verso l’esperienza virtuale, alla quale riconosce quella multiforme versatilità di cui esso non dispone, costretto dalla propria inesorabile aderenza alla dimensione materiale. Spazi sempre più ampi vengono concessi ai dispositivi di simulazione, i quali a poco a poco abbandonano gli universi sintetici della virtualità e scendono a contesa con la realtà sul suo stesso terreno. Non soltanto ne insidiano il potere di persuasione a livello percettivo, ma si insinuano nel medesimo contesto materiale di riferimento. Si liberano progressivamente dal tradizionale marchio di apocrifa ambiguità che li relegava nel territorio astratto del non-essere, e conquistano una loro attendibilità– anche morale – che ne legittima la grande entrée sulla scena dell’oggettività.
In questa prospettiva, vorrei soffermarmi su due pellicole del 2009, riconducibili entrambe al filone della realtà simulata: Il mondo dei replicanti e Avatar. In questi film, i dispositivi di simulazione non consentono di accedere a un mondo fittizio (ludico, didattico, onirico, mentale, o legato alla fiction, alla rappresentazione), ma consistono in degli androidi che abitano e si muovono nella materialità corporea del mondo reale. Nel Mondo dei replicanti il 98% degli esseri umani dispone di un surrogato, un corpo artificiale modellato a immagine e somiglianza del proprietario ma con una marcata riduzione dei difetti estetici. La fisicità della carne – fatta di caducità e di imperfezione – viene vissuta con pudore e dispetto. La responsabilità di interfacciarsi con gli altri viene delegata completamente al surrogato. Il corpo reale vive rinchiuso in una sorta di loculo, incessantemente collegato al replicante tramite degli appositi sensori che consentono di percepirne gli stimoli e comandarne i movimenti attraverso il cervello.
Il concetto di simulazione subisce uno sfasamento determinante: l’ambiente nel quale si svolge la simulazione non è più un ambiente virtuale, ma la realtà stessa, mentre, per assurdo, è il corpo reale a vivere in un ambiente fittizio, iperprotetto e conservativo. I replicanti sembrano in grado di salvaguardare il genere umano dall’istintivo terrore nei confronti dell’irreversibile, vivendo e rischiando al posto loro nel mondo reale. Tuttavia, per quanto tecnologicamente assai sofisticati, essi non possono evitare agli uomini il naturale destino della consumazione. L’agente Greer (il protagonista della storia), che con la scomparsa di suo figlio ha sperimentato il dramma dell’irreversibilità nella maniera più tragica, comprende che l’unico modo per risollevarsi dal trauma della perdita consiste nell’accettare la caducità della condizione umana e la natura transeunte dell’esperienza nel tempo. Sceglie di tornare a vivere nella sua dimensione corporea, senza più temere la malattia, l’invecchiamento e la morte; rinuncia all’illusorio conforto della simulazione e ristabilisce il primato morale dell’esperienza reale su quella virtuale.
In Avatar, i militari terrestri sono impegnati nella colonizzazione del pianeta Pandora allo scopo di depredarlo dell’unobtainium, un formidabile superconduttore in grado di risolvere i gravissimi problemi energetici della Terra del ventiduesimo secolo. Per appropriarsi del prezioso minerale, gli esseri umani sono pronti a sconvolgere la delicata armonia del pianeta, ma devono fare i conti con un’inattesa resistenza, non soltanto da parte della popolazione aliena dei Na’vi, ma anche dello stesso ambiente naturale, nel quale coesistono forme di vita spaventosamente micidiali con altre di poetica levità. Jake Sully – un ex marine costretto su una sedia a rotelle in seguito a un incidente militare –viene fatto infiltrare tra i Na’vi con l’ausilio di un avatar, un corpo sintetico costruito in laboratorio combinando DNA extraterrestre con quello umano. Jake ha il compito di conquistare la fiducia dei nativi e di convincerli a lasciar entrare le forze terrestri sul pianeta. Sottoposto a una dura iniziazione per essere accettato dalla comunità aliena, nel nuovo corpo artificiale il tenente Sully riscopre la padronanza dei propri movimenti e si innamora di Neytiri, la giovane figlia del grande capo. La sua esistenza subisce una sorta di sdoppiamento: Jake arriva al punto di percepire la coscienza nel corpo come sogno, e la vita nell’avatar come realtà.
Anche in questo film è il corpo virtuale ad avere un’esperienza nel mondo vero, mentre il corpo reale si ritrova in uno stato di inattività. Ma – diversamente da quanto accade nel Mondo dei replicanti– in Avatar la dimensione della simulazione acquisisce un’inedita preminenza morale sulla realtà. Nel mondo reale, Jake trascorre su una sedia a rotelle un’esistenza piena di rimpianti, è un militare che combatte una guerra detestabile contro una popolazione pacifica e valorosa, e non ha la possibilità di avere una storia sentimentale con Neytiri. Nella simulazione, viceversa, egli dispone di un corpo dotato di forza e agilità, dimostra il proprio coraggio prendendo posizione contro i terrestri, e può vivere in pienezza la propria passione per la giovane principessa Na’vi. Sulla base di tutti questi presupposti, Jake compie un’opzione sorprendente a favore della simulazione: rinnega l’insoddisfacente contingenza della propria natura e della sua stessa corporeità, e decide di costruirsi una nuova identità, non in base a ciò che è, ma a ciò che intende diventare, trasfondendo – grazie all’intervento di una divinità aliena – il suo spirito vitale dal corpo menomato nel vigoroso avatar. Lo strato di isolamento fra la dimensione reale e quella simulata subisce una sorta di cortocircuito esistenziale: la simulazione assume i rigidi connotati della concretezza e i surrogati rubano definitivamente ai viventi la scena della realtà.
Torna alla memoria un altro celebre replicante, l’androide Roy Batty di Blade Runner, le cui ultime parole sono ormai entrate a far parte di un codice condiviso ben noto anche ai non appassionati del genere science fiction. Roy apparteneva alla serie speciale di replicanti Nexus 6, che (a differenza delle più antiche) era stata programmata per maturare emozioni proprie, e dunque una consapevolezza. Per evitare che la coscienza di sé ne attestasse – cartesianamente – un’ontologia, il progettista aveva assegnato a tali esemplari una data di scadenza: dopo quattro anni di vita, un dispositivo di sicurezza poneva termine alla loro esistenza, lasciando agli esseri umani l’indiscussa signoria del tempo e della verità. Al termine di un epico scontro con il poliziotto Rick Deckard, al sopraggiungere della fine, Roy mormorava mestamente: «Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia». Escluso dalla prestigiosa giurisdizione dell’autenticità, Roy rivendicava la preminenza della propria esistenza virtuale, non costretta dai limiti angusti cui sono necessariamente assoggettati i viventi, e si rammaricava per l’odioso atto di arroganza con cui veniva iniquamente estromesso dalla storia. Oggi il suo rammarico sembra finalmente trovare consolazione, mentre la simulazione attesta il suo scabroso diritto di cittadinanza nell’aspro territorio dell’effettività.